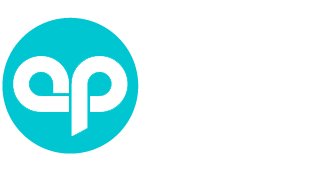L’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza ONU della risoluzione 1325 nel 2000 codificò l’impegno internazionale a promuovere il ruolo delle donne nei processi di pace. La risoluzione portò anche a un netto aumento dei finanziamenti mirati a migliorare la situazione delle donne, specialmente in contesti caratterizzati da guerra e violenza. Nel corso degli anni, tuttavia, la forza della risoluzione 1325 è fortemente diminuita, almeno nella misura in cui l’impatto degli interventi appoggiati in suo nome non si è concretizzato. È anche venuta a mancare una direzione precisa nei tanti interventi appoggiati a livello globale. La retorica della risoluzione sussiste, in altre parole, ma la realtà, in tanti paesi, non viene intaccata.
La situazione delle donne del Corno d’Africa riflette questo contrasto pienamente. Da una parte, la regione—che include il Djibouti, l’Eritrea, l’Etiopia, il Kenya, la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan e l’Uganda—ha accolto a braccia aperta la risoluzione 1325: l’Inter-governmental Authority on Development (IGAD), la principale organizzazione regionale per le politiche di pace e sicurezza, ha adottato un piano regionale per l’implementazione della risoluzione nel 2014, dopo aver sponsorizzato tanti eventi e consultazioni, e nel 2015 ha anche ufficialmente creato un forum per le donne e la pace. Anche a livello dei singoli stati non sono mancate proclamazioni in favore della risoluzione. In Uganda, per esempio, un piano nazionale fu approvato dal governo già nel 2008; e quasi tutti gli stati hanno ormai adottato quote rosa per parlamentari e funzionari governativi.
La realtà in quasi tutti i paesi del Corno rimane tuttavia ben diversa. I diritti delle donne vengono regolarmente violati e la loro partecipazione politica è sistematicamente ostacolata. I casi peggiori sono quei paesi dove c’è violenza armata: Somalia, Sudan e in particolar modo il Sud Sudan, la cui guerra civile del 2013-2015 ha vittimizzato soprattutto le donne: “ci sono pochi posti al mondo”, scrive l’ONG britannica CARE International, “dove crescere donna è più pericoloso o degradante che in Sud Sudan.” Dinamiche di marginalizzazione sussistono tuttavia anche nei paesi con più stabilità: in Djibouti più del 90% delle donne è soggetto alla mutilazione genitale; nelle zone rurali dell’Etiopia, uno studio indica che le donne spesso devono lavorare dalle 15 alle 19 ore per giorno, gli uomini solo dalle 5 alle 13; ed in tutti i paesi, codici civili co-esistono con sistemi legali tradizionali o islamici che spesso limitano i diritti delle donne—in Sudan, per esempio, le donne possono lavorare solo col permesso del marito o del padre.
Ci sono ovviamente anche degli sviluppi positivi. Il sistema di quote rosa ha aumentato i numeri di donne nei governi di quasi tutti i paesi del Corno. E a livello di società civile, organizzazioni di donne sono nate ovunque, arrivando anche a formare dei veri e propri movimenti femministi, come l’Ugandan Women Network in Uganda. Eppure, e nonostante questi successi, il divario tra la retorica della risoluzione 1325 e la realtà rimane ampio. Perché?
Tra le tante (e dibattute) ragioni, AP ne offre tre, tutte basate sulla nostra analisi:
Primo, gli interventi a favore della risoluzione 1325 sono spesso sconnessi dalle dinamiche di sistema che causano la marginalizzazione e la vulnerabilità delle donne. In Sud Sudan, per esempio, tante ONG lavorano per facilitare la partecipazione delle donne nei processi di pace, ma solo il 16% delle donne sa leggere e scrivere. Questa statistica non può essere semplicemente ignorata da chi si occupa di peacebuilding.
Secondo, il focus della risoluzione 1325 è diventato troppo ampio. L’impatto maggiore fino ad ora è, infatti, stato ottenuto non con interventi che vogliono migliorare la situazione economica delle donne o combattere la violenza domestica, ma con iniziative mirate a influenzare processi decisionali. In Somalia, per esempio, l’adozione della risoluzione nel 2000 permise a diverse donne di partecipare alla conferenza di Arta, organizzata lo stesso anno dal governo del Djibouti per mediare tra le parti in conflitto. In quest’occasione, scrive l’attivista somala Faiza Jama, “le donne riuscirono a convincere il presidente del Djibouti a sponsorizzare la loro partecipazione alla mediazione e a garantire 25 posti sui 245 del neo-parlamento.”
Terzo, il successo nel promuovere la partecipazione delle donne può essere raggiunto solo dove esiste uno spazio civile e politico aperto—cosa che, sfortunatamente, sta velocemente diventando una rarità in tutti i paesi del Corno. In Etiopia, per esempio, la legge che regola le attività di associazioni proibisce di lavorare su riforme politiche e diritti umani. E anche in Uganda, uno dei paesi più liberali, il parlamento ha recentemente adottato una legge che limita le attività della società civile. Queste azioni non sono compatibili con gli impegni dettati nella risoluzione 1325—una cosa che dovrebbe essere detta dalla comunità internazionale, ma che troppo spesso non lo è.
La partecipazione delle donne al peacebuilding è uno dei temi chiavi per il lavoro di AP. La pace non può, infatti, essere realizzata dove la metà della popolazione non ha diritti o accesso a opportunità genuine di partecipazione politica e civile. Per questo, AP aiuta chi lavora nel settore ad avere un impatto maggiore, attraverso l’analisi e la ricerca, l’advocacy e la sensibilizzazione.