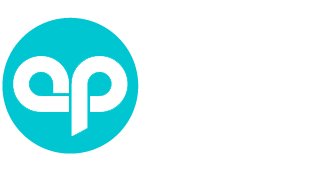L’IMPORTANZA DI ESSERE SENSIBILI AI CONFLITTI
Ho svolto una delle mie ultime missioni in Chad, dove ho condotto un’analisi di conflitto per una’agenzia di sviluppo che lavora nel paese. Stavo facendo ricerca sul campo in una regione in cui era appena scoppiata un’epidemia di colera, e mi trovavo lì proprio nel culmine della crisi, quando diverse ONG sono arrivate sul posto per occuparsi dell’emergenza sanitaria. Dati i bisogni, queste organizzazioni hanno cominciato a realizzare i loro programmi senza preoccuparsi troppo di cosa facessero, come, con chi, o dove.
Qualche giorno più tardi, stavo parlando con un operatore umanitario responsabile di uno di questi programmi d’emergenza. Era frustrato, perché qualche ora prima aveva scoperto che alcuni pazienti avevano rifiutato di presentarsi al centro per il trattamento del colera, e in questo modo avevano contagiato familiari e vicini. Quel giorno, l’operatore umanitario aveva semplicemente scoperto ciò che la popolazione e le organizzazioni locali sanno da tempo: una parte della popolazione del canton (l’unità amministrativa locale) non riconosceva più l’autorità dello chef de canton (l’autorità tradizionale scelta dal governo). Queste persone venivano chiamate opposants, o oppositori. Quando è scoppiata l’epidemia, le ONG hanno immediatamente installato il centro di trattamento del colera a fianco agli ospedali già esistenti. In questo canton, tuttavia, l’ospedale si trovava in una zona popolata da famiglie fedeli allo chef de canton. Poiché la tensione tra queste persone e gli opposants era alta, questi ultimi non osavano addentrarsi in un territorio a loro ostile. Di conseguenza, l’ONG non è riuscita a raggiungere questi pazienti, che quindi non sono stati curati ed hanno finito per contagiare familiari e vicini.
Questo esempio illustra come la mancanza di conoscenza del contesto e dei conflitti nelle zone in cui s’interviene possa arrecare danni imprevisti. Nel rispondere a queste situazioni, già negli anni novanta, le agenzie di aiuto umanitario cominciarono a investire risorse per capire come evitare le conseguenze negative e involontarie dell’aiuto umanitario. Ricercatori e operatori cominciarono a chiedersi se esistessero approcci diversi all’aiuto umanitario, o se tali conseguenze negative fossero semplicemente inevitabili. Questi lavori culminarono nella pubblicazione del libro “Do No Harm: How Aid Can support Peace or War” di Mary B. Anderson, nel 1999. Da allora, le agenzie umanitarie hanno cominciato a usare l’approccio Do No Harm (Non nuocere) al fine di monitorare l’impatto dell’assistenza umanitaria in zone di conflitto. Allo stesso tempo, donatori e organizzazioni multilaterali hanno cercato di integrare il Do No Harm nei loro interventi, come base per la creazione di pratiche sensibili al conflitto nell’assistenza umanitaria. L’approccio Do No Harm ha tre presupposti di base: i) l’aiuto non è neutro; ii) l’aiuto è un trasferimento di risorse, quindi un oggetto di competizione; iii) a seconda di come l’aiuto è fornito, questo può mitigare i conflitti, o fomentarli.
Quasi 20 anni dopo la pubblicazione del libro di Mary Anderson, si avverte ancora il bisogno di una vera integrazione del Do No Harm nell’aiuto umanitario. Sebbene diverse metodologie e corsi di formazione esistano e siano accessibili agli operatori del settore, rimangono diversi ostacoli per un’effettiva integrazione di tale approccio. Fra questi, vale la pena di citarne due. Innanzitutto, molte ONG sono persuase che condurre un’analisi di conflitto in qualsiasi contesto sia una violazione di un loro principio fondamentale: la neutralità. In altre parole, c’è la percezione secondo cui il semplice fatto di chiedersi (e chiedere) quali siano gli attori implicati nel conflitto, e per quali ragioni, diminuisca la neutralità (o la percezione di neutralità) delle ONG. Il secondo ostacolo consiste nella convinzione secondo cui i settori d’aiuto umanitario delle ONG non coinvolgono interventi inerenti a risoluzione dei conflitti o la riconciliazione, e per questo l’analisi di conflitto, o un approccio sensibile al conflitto, sarebbe quindi irrilevante.
Tuttavia, come conferma l’esempio all’inizio dell’articolo, il conflitto può avere conseguenze molto negative sulle attività e sui progetti degli operatori umanitari, arrivando anche a influenzare la percezione della loro neutralità da parte dei beneficiari. A questo riguardo, la ricerca condotta su questo tema negli ultimi anni ha reso evidente che la consapevolezza dell’interazione tra l’intervento e il contesto nel quale esso si sviluppa non incide sulla neutralità delle ONG, ma è un punto di partenza importante per evitare di arrecare danno. Allo stesso modo qualsiasi intervento, sia esso su sicurezza alimentare, salute e igiene, o agricoltura, può e deve essere sensibile al conflitto.
Se è vero che un progetto sensibile al conflitto non ha bisogno di promuovere la pace come suo obiettivo primario, le conoscenze acquisite finora rendono chiaro che è altrettanto vero che un tale approccio andrebbe sempre a favore dell’efficacia e dell’efficienza dell’aiuto umanitario in generale.