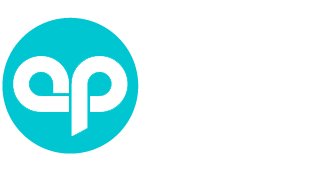DOPO NIZZA: IL BISOGNO URGENTE DI TROVARE UN NUOVO APPROCCIO ALLA LOTTA AL TERRORISMO
Nizza e Saint Etienne-du-Rouvray sono gli ultimi dei massacri che, a cominciare dagli attacchi dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, hanno contribuito a creare lo stato d’insicurezza in cui tutto il mondo sembra trovarsi in questi giorni. Eppure, non è ancora chiaro perché queste azioni continuino ad avere luogo, così come non si capisce ancora quale sia la vera natura di al-Qaida, ISIS e altri gruppi paramilitari islamisti. Per porre rimedio a questo, c’è il bisogno urgente di una riflessione critica e profonda sul perché non si riesca a comprendere questi fenomeni. Innanzitutto, bisogna riconoscere che uno degli ostacoli più grandi alla nostra comprensione è da cercare nel fatto che sia gli esperti sia il pubblico più in generale tendono a vedere gruppi come l’ISIS come una minaccia esistenziale a sé stante. Sarebbe invece meglio, come suggerisce Paul Rogers nei suoi articoli per openDemocracy.net, vedere questi gruppi comi sintomi di una situazione molto più grande e complessa, e caratterizzata da tattiche di guerra irregolari.
In quest’ottica, al-Qaida, ISIS e altri gruppi paramilitari dello stesso tipo riflettono uno stato molto più ampio d’insicurezza globale, le cui cause, per usare le parole di Rogers, sono “le crescenti divisioni socio-economiche, che portano alla relativa marginalizzazione della maggior parte delle persone nel mondo, e la prospettiva di limitazioni profonde e durature riguardo all’ambiente, che sono causate dai cambiamenti climatici. L’ascesa dell’ISIS, in altre parole, dovrebbe essere vista come un avvertimento di quello che potrebbe succedere e non come una dinamica fondamentale in se stessa”. Rogers sottolinea che “l’ISIS è un esempio di rivolta che comincia dai margini”. Questa è la ragione per cui non c’è, né ci potrà mai essere, una soluzione militare a quest’ondata di terrorismo. E, d’altra parte, molti accademici e politici hanno ormai da tempo concluso che la cosiddetta “guerra al terrorismo” ha fatto molto più male che bene. Eppure, l’approccio militare alla lotta al terrorismo continua a prevalere in tutto il mondo, mentre l’uso di strumenti sociali e culturali, il cosiddetto soft power, rimane l’eccezione.
Nel dire questo, bisogna anche riconoscere che molti politici europei e americani hanno già dimostrato un forte interesse per politiche mirate a prevenire la radicalizzazione, soprattutto all’interno di comunità di religione islamica. La maggior parte di queste politiche sono state, tuttavia, concepite e applicate in modo sbagliato, portando invece all’erosione della fiducia che queste comunità hanno verso lo Stato. Le politiche di prevenzione della radicalizzazione hanno portato, infatti, alla stigmatizzazione di questi gruppi, ottenendo l’effetto contrario a quello sperato. Il problema di questo fallimento è da cercare nelle modalità di definizione del termine ‘radicalizzazione’ da parte dello Stato, che Simon Cottee descrive come “un processo graduale in cui delle persone adottano degli atteggiamenti e delle credenze sempre più estremi…Il presupposto è che mentre non tutti i radicali diventano terroristi, tutti i terroristi sono radicali.” Eppure, aggiunge Cottee, i casi più recenti di terrorismo sembrano demolire questo presupposto, e portano a galla alcune difficili domande: “e se queste persone non fossero state ‘radicalizzate’ e non avessero completato alcun processo di metamorfosi?”, e “se il copione del terrorismo non includesse ogni volta il dramma della radicalizzazione?”
Svariati accademici e analisti hanno offerto diverse spiegazioni riguardo alla genesi e alle cause degli atti di terrorismo, anche molto diverse tra di loro. Tutte contengono probabilmente qualcosa di vero, ma nessuna riesce a cogliere appieno quali siano i fattori sociali e psicologici che spingano una persona a compiere un atto violento in nome di un’organizzazione estremista.
Dopo eventi come quelli di Nizza e di Saint Etienne-du-Rouvray, il bisogno di riflettere in modo critico e profondo sull’efficacia dell’attuale approccio alla lotta al terrorismo diventa più urgente che mai. Un buon punto di partenza, sia per i politici che per gli accademici, sarebbe ammettere che le attuali dinamiche di sicurezza globale sono estremamente complesse, e che non ci possono essere delle soluzioni immediate al problema del terrorismo. Sarebbe anche opportuno accettare, in modo esplicito, che un approccio cinetico (ovvero incentrato sulla risposta violenta alla violenza) non può e non potrà mai rappresentare la soluzione definitiva al problema. Ciò che invece risulta necessario, è un maggiore impegno per capire il quadro generale, la malattia sociale di cui gli ormai frequenti attacchi sono il sintomoper usare una metafora medica.
È soltanto partendo da questo presupposto che ci si potrà allontanare dall’approccio puramente militare attualmente in voga e arrivare a definire delle strategie che siano veramente capaci di opporsi, in maniera efficace e sostenibile, alla logica del terrorismo moderno.
La versione originale di quest’articolo è stata pubblicata su openDemocracy.net il 18 luglio 2016.